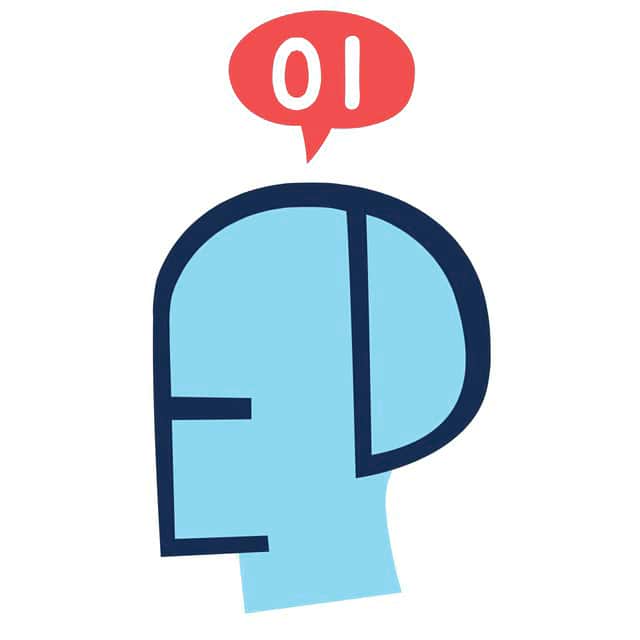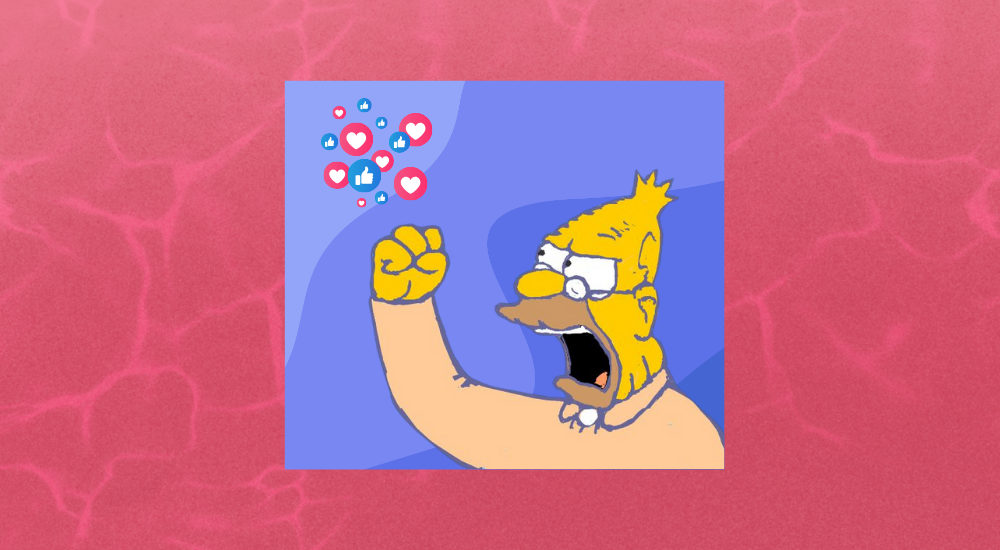Una bella newsletter del, spesso ottimo, Davide Piacenza. Se vi piace potete iscrivervi alla sua newsletter chiamata Culture Wars.
Non so voi, ma dal mio piccolo e secluso osservatorio mi sembra che negli ultimi tempi sempre più persone si prodighino ad amplificare un discorso riassumibile – coi limiti costitutivi di ogni riassunto – come segue: ogni critica a una nuova tecnologia, al fondo, è legata alle altre dal minimo comune denominatore di una commistione di nostalgia retrograda, panico morale luogocomunista («dove andremo a finire, signora mia?») e antipatia viscerale per le nuove forme di espressione o comunicazione.
Da persona che negli ultimi anni si è messa quasi ogni giorno lo scafandro da palombaro per immergersi nelle profondità delle nostre vite socialmediali iperconnesse, ritengo che questa lettura sia insensata, banale, superficiale, ma soprattutto pericolosa.
Ok, Piacenza, però tu sei il primo a essere sui social: co-e-ren-za. Sì, certo, e questo è un primo punto da smarcare, a mo’ di disclaimer: sono sui social perché, dopo quindici anni di frequentazione, credo di aver finalmente imparato a starci in una maniera che non ha effetti nocivi sulla mia salute; il che implica utilizzarli il meno possibile, e soprattutto non illudermi di poterci discutere di politica, o di cultura, o di sport.
Anzi, meglio ancora: significa non illudermi di poterli usare per discutere, full stop. In altre parole, sto evitando accuratamente la destinazione d’uso per cui erano stati originariamente pensati e sviluppati, nonché il campo d’azione per cui ne abbiamo collettivamente incensato le ricadute sulla società per più di un decennio. E persino con questo modus operandi segnato da paletti abbastanza stretti, non di rado torno ad arrabbiarmi, a essere frustrato dalle loro logiche, a volermene allontanare, a chiedermi perché non costruiamo un’alternativa.
Parlo al plurale, anche perché io stesso sono stato un loro sostenitore relativamente accanito (online si trovano facilmente articoli che ho scritto nell’arco di anni, su diverse riviste): giubilavo quando l’allora Twitter sospingeva il vento delle Primavere arabe, nel 2011-12; mi entusiasmavo osservando e raccontando i primi progetti giornalistici spuntati sulle piattaforme; detta semplicemente, credevo che stessero migliorando il mondo.
Poi cos’è successo? Sono diventato vecchio e scorbutico? Ho iniziato a guardarli come l’America perbenista degli anni Cinquanta guardava il rock’n’roll di Little Richard e Jerry Lee Lewis, stringendo con costernazione i suoi rosari? Mi sono convinto che i social siano vettori di corruzione morale e intellettuale, come i critici letterari ottocenteschi pensavano dei racconti e dei romanzi? Gli inquadramenti offerti dall’estremità dei filo-social, stringendo, sono questi.
E tutto può essere, ma se c'è una prassi che non mi fa difetto, di norma, è l’autocritica; credo proprio che il problema risieda altrove. Intendiamoci, peraltro: non c’è dubbio che tra chi critica i social media (o gli smartphone, o l’intelligenza artificiale, o i razzi per andare su Marte, eccetera) ci sia una folta schiera di passatisti in malafede, di persone con rendite di posizione da difendere, di torri d’avorio interessate a non dilapidare il loro privilegio.
Ma se tutte le prefiche che si lagnano della polarizzazione e le altre storture di quest’epoca hanno sempre torto, come sostengono variamente i più accesi sostenitori del sol dell’innovare che leggo e ascolto, perché dargli la soddisfazione di vedere indirettamente confermate le loro critiche, facendo di tutta l’erba un fascio a cui destinare un commento derisorio, à la ok, boomer?
Come dice a un certo punto Fran Lebowitz nel documentario recentemente prodotto da Netflix che le ha dedicato l’amico Martin Scorsese, «la gente pensa che io non abbia i social perché non so cosa sono: invece ne sto alla larga proprio perché lo so».
Come lei – si parva licet, da ultimo anche perché ho appena compiuto 35 anni – ho assunto posizioni critiche degli algoritmi e delle piattaforme perché mi sono fatto idee più chiare, studiandoli, di come funzionano e di cosa provocano. E così è successo a tanti altri. In Italia è uscito da pochi giorni La generazione ansiosa (Rizzoli), un saggio di Jonathan Haidt, psicologo e autore newyorkese da tempo attivo nel sensibilizzare sulle ricadute dell’uso massivo dei social media sugli adolescenti.
Oltreoceano il saggio è diventato un caso editoriale, ha ricevuto molte lodi e anche diverse critiche; invito chiunque a leggerlo, perché ha un primo incontestabile merito: avviare una conversazione – di portata internazionale – intorno alle vittime silenziose di un sistema comunicativo che prendiamo per inevitabile, immodificabile, e a cui siamo sempre più assuefatti.
*removed externally hosted image*
Chi non ha a che fare da vicino con adolescenti depressi che hanno sviluppato una dipendenza da social media potrà fare spallucce di fronte al problema, ed è possibile – lo dicono alcuni suoi detrattori – che Haidt ingigantisca alcuni numeri o si sia messo alla testa di un movimento di portavoce online che non vuol saperne di cautele e sfumature, finendo per somigliare all’oggetto della sua critica.
Ma per accorgersi del fatto che le dipendenze da social, doviziosamente incanalate dalla dopamina dei like e dell’engagement a tutti i costi, colpiscono in modo sproporzionato le persone più fragili non ci vuole uno studio comparato: basta guardarsi intorno. Chiunque di noi ha alcune conoscenze che, come si dice di solito, sui social sono «irriconoscibili», come se passassero con un tocco di interruttore da dottor Jekyll a Mr. Hyde, dedicando le loro giornate a battagliare con veemenza crescente contro nemici algoritmici scelti apposta per loro.
Ecco: queste cose non succedono per caso. La colpa non è da imputare all’imperizia e all’impulsività di quel singolo Jekyll, o non soltanto: scelte di business precise e consapevoli – l’introduzione del tasto «Like» e della relativa conta di «mi piace», il passaggio al News Feed algoritmico di Facebook, l’intera architettura nativa di TikTok – dell’ultimo decennio hanno portato a un mondo in cui l’importante non è comunicare con gli altri, ma produrre engagement e contenuto da diffondere il più possibile.
Le suddette teorie sono a tal punto ostaggio di reazionari che stringono rosari e mandano in riparazione il grammofono, che a farle proprie sono alcuni decani della Silicon Valley; gente che ha partecipato attivamente all’evoluzione di queste tecnologie, per capirci. Fra loro c’è uno studioso che cito spesso (anche nel mio libro): è Jaron Lanier, pioniere del software libero e della realtà virtuale, che chiama quelli di Meta e le altre multinazionali del digital «imperi della modificazione comportamentale», per sottolineare il modo surrettizio, graduale ma deliberatamente inesorabile in cui ci costringono a mettere da parte l’umanità condivisa per alimentare il fuoco delle divisioni artefatte (e con esso, si diceva, l’engagement monetizzabile in chiave inserzionistica).
Un’altra grande penna da leggere su questi temi è quella di Ian Bogost, critico dell’Atlantic, che non è diventato un detrattore dei social media perché si stava meglio quando si stava peggio o simili, ma perché li ha visti crescere e prendere strade brutali e pavloviane. Scriveva Bogost pochi anni fa: